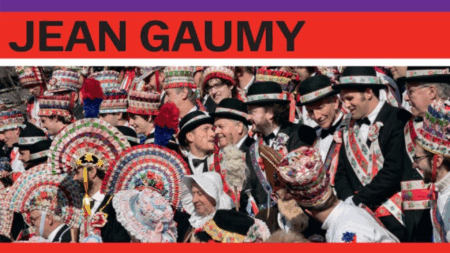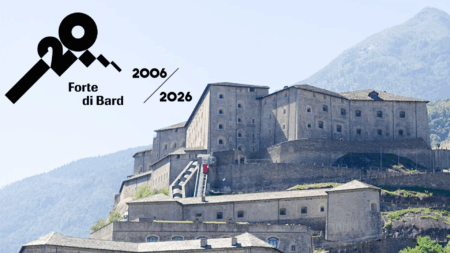Il 25 giugno 2025, l’Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy ha ospitato la presentazione della “Certificazione della biodiversità degli ecosistemi in Valle d’Aosta”. Il progetto, promosso dall’Institut Agricole Régional, dalla Cave Mont-Blanc de Morgex et La Salle, da Coldiretti Valle d’Aosta, dal Comune di Nus, dall’ente di certificazione CSQA e dal Parco Naturale Mont Avic.
Sostenuto dal ramo valdostano del Programma di Sviluppo Rurale 2023–2027 – europeo ma centralizzato a livello statale italiano – nasce con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale e valorizzare le specificità agricole locali attraverso un sistema innovativo di riconoscimento ecologico.
L’iniziativa si colloca nel quadro delle azioni internazionali per la tutela della biodiversità, avviate con il programma delle Nazioni Unite per il Decennio 2020–2030 sullo sviluppo sostenibile, recepite dall’European Green Deal. Malgrado i processi di revisione anche in ragione di aumento della spesa militare, ha già avviato a cascata una serie di interventi negli Stati membri orientati a ridefinire il rapporto tra uomo e ambiente, in un’ottica di equilibrio, corresponsabilità e rigenerazione. Gli Interventi, in ogni caso, necessitano di monitoraggio al fine di valutarne impatti economici, sociali e scongiurare rischi di greenwashing ed elitizzazione che possono escludere, per ragioni economiche, alcuni Stati o territori.
La storia delle Certificazioni della biodiversità, oltre la Valle d’Aosta
Le prime certificazioni di biodiversità nascono dalla Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) firmata, a Rio de Janeiro nel 1992, da 150 leader governativi, che hanno riconosciuto la biodiversità come patrimonio globale e come la più importante risorsa dei sistemi naturali del pianeta. Nonostante gli intenti, le convenzioni sancite allora hanno tardato a trovare progetti attuativi, mentre la perdita di biodiversità si è aggravata, a sua volta, con l’implementare di attività umane quali l’agricoltura intensiva, l’urbanizzazione e il cambiamento climatico, aspetto evidenziato anche nei rapporti delle Nazioni Unite.
Le prime direttive europee che hanno posto le basi per il monitoraggio e la promozione di standard per la conservazione della biodiversità nel continente europeo sono state, nel 1992, le Direttive Habitat che hanno fornito una base normativa di tutela incentivando sistemi di monitoraggio e certificazione.
Nel settore agroalimentare le certificazioni specifiche per la biodiversità sono rare, più facilmente integrate in standard più ampi, come quello della Produzione Integrata (SQNPI), o delle Certificazioni biologiche (Reg. UE 2018/848) che promuovono la tutela della diversità naturale attraverso pratiche come la riduzione dei pesticidi, ma sono prioritariamente orientate a tecniche agronomiche.
Lo stato delle cose in Francia e Svizzera
In Francia nel 2011 è stato introdotto il HVE (Haute Valeur Environnementale che accredita le aziende agricole che riducono l’impatto ambientale con criteri per la biodiversità.
L’Office Français de la Biodiversité (OFB), propone il Label Biodiversité, una certificazione per la gestione sostenibile degli ecosistemi, in particolare in aree agricole e forestali.
In Svizzera BioSuisse, che regola lo standard biologico elvetico, include anche requisiti per la biodiversità, certificando, ad esempio, nel Vallese, aziende che proteggono varietà alpine.
Il protocollo World Biodiversity Association applicato in Valle d’Aosta
La “Certificazione della biodiversità degli ecosistemi in Valle d’Aosta” applica il protocollo di World Biodiversity Association (WBA), associazione fondata nel 2004 a Verona con lo scopo di censire e tutelare la varietà degli ecosistemi, mettendo al centro gli agricoltori quali i custodi dell’integrità ambientale del territorio.
La WBA nel 2010 ha avviato Biodiversity Friend®, uno schema di certificazione volontario patrocinato dal Ministero italiano delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che valuta aziende agricole che proteggono la biodiversità attraverso indicatori come la qualità del suolo e la presenza di impollinatori. Il sistema è diffuso in Veneto, Toscana ed Emilia-Romagna, specialmente nel settore vitivinicolo.
Il progetto valdostano vuole coinvolgere in un circolo virtuoso gli stakeholder locali per promuovere sostenibilità e competitività, migliorare la qualità delle produzioni agroalimentari locali, rafforzare l’identità del territorio e promuovere la consapevolezza di produttori e consumatori verso le tematiche ambientali.
Opportunità e criticità della certificazione della biodiversità degli ecosistemi in Valle d’Aosta
In un mercato sempre più orientato alla sostenibilità, il marchio offre l’opportunità di valorizzare l’economia alpina e il turismo “verde” aumentando la competitività e il valore percepito dei prodotti valdostani.
Inoltre, il rapporto dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA 2023), sottolinea che gli indicatori di biodiversità aiutano a prevenire la degradazione degli habitat, portando a benefici misurabili, come la protezione di specie, il miglioramento della qualità del suolo o l’aumento della resilienza degli ecosistemi.
Le criticità che potrebbero evidenziarsi sono i costi, per produttori e consumatori, che potrebbero limitare le adesioni al sistema. A questi si aggiungono possibili impatti ecologici indiretti, ad esempio legati all’uso di packaging dedicati, e il rischio di pratiche di greenwashing.
È quindi importante, come previsto negli intenti del progetto, adottare standard rigorosi e un sistema di monitoraggio scientifico basato su verifiche indipendenti. Altrettanto essenziale è mantenere un dialogo costante con il territorio in grado di far emergere sia le criticità che le opportunità di miglioramento.
Sarà così possibile costruire un percorso realmente innovativo, efficace e replicabile, capace di coniugare sostenibilità ambientale coinvolgimento delle comunità locali e successo economico.
LEGGI ANCHE: Acqua nelle Alpi, futuro incerto: il Forum di Schaan