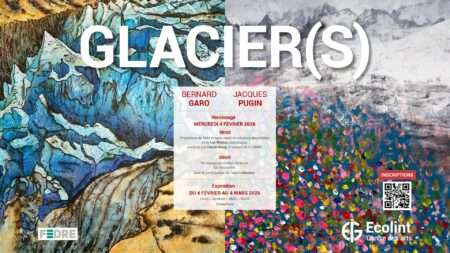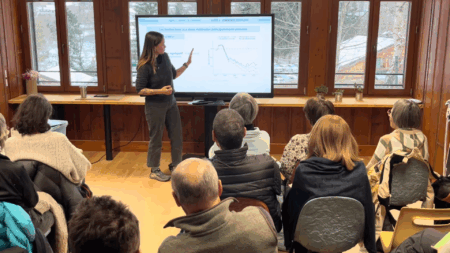Nell’ultima sua newsletter, che diffonde su Substack, Sévérin Duc ripercorre l’esperienza di Warren Buffett con Berkshire Hathaway, da fabbrica tessile in crisi negli anni Sessanta a nuova holding di successo nel settore finanziario, per trarne una lezione applicabile alle regioni alpine e alle stazioni turistiche invernali.
Séverin Duc segue ormai da un po’ di tempo la questione dell’evoluzione della montagna turistica, in particolare francese, alla luce sia del cambiamento climatico sia dell’economia e della società. È una delle voci di un dibattito che è certamente più vivace nelle Alpi francesi rispetto all’Italia o alla Svizzera.
In Italia, il peso delle stazioni invernali è minore e l’attenzione rimane sulla montagna che si spopola, come mostra la ricerca di Il Rapporto montagne Italia dell’Unione dei Comuni montani italiani. In Svizzera sembra prevalere un adattamento tecnico e di modello di business ai cambiamenti climatici, nella constatazione attuale dell’aumento di entrate per le grandi stazioni.
Ci sono tuttavia, sempre in Francia, altre voci da tenere in conto, come quella di Laurent Reynaud, délégué général dei Domaines Skiables de France, che è intervenuto il 3 novembre a una tavola rotonda sullo stesso tema a Grenoble Ecole de Management.
Reynaud dice per esempio, di fronte a posizioni più nette sull’abbandono delle politiche dello sci, che il modello rimane, e deve essere aiutato ad evolvere. Le occasioni di questo dibattito sono varie. Allo stesso salon international du livre de Passy vi fu una sessione dedicata a questo tema, in cui partecipò un’altra voce significativa di questo dibattito xx Guillaume Desmurs.
Ma veniamo al ragionamento di Séverin Duc nella sua newsletter, su Warren Buffet, il tessile e il futuro delle Alpi.
Il caso di Warren Buffet nel tessile
Buffett acquistò Berkshire Hathaway nel 1965, trovandosi subito di fronte a un’industria in declino strutturale. Nonostante la dedizione degli operai e la qualità del management, la competizione globale e i margini sempre più bassi rendevano ogni investimento nel tessile sempre più inefficace.
Nel 1967, Buffett smise di reinvestire nel tessile e acquistò invece una compagnia di assicurazioni, National Indemnity, aprendo la strada a una diversificazione radicale. Solo nel 1985 decise definitivamente di chiudere il ramo tessile, riconoscendo che le risorse spese per “colmare le falle” erano improduttive rispetto a un cambio di rotta.
Duc sottolinea come Buffett abbia agito con prudenza e responsabilità sociale (riconoscendo il ruolo delle sue aziende tessili nelle comunità territoriali, per il lavoro e lo sviluppo) ma anche con la lucidità necessaria per interrompere un modello economico non più sostenibile e cercare una seconda strada.
Le Alpi e la crisi del turismo invernale
Duc trasferisce questa riflessione alle Alpi contemporanee. Le stazioni sciistiche, in particolare quelle di media quota, si trovano in una situazione simile: un modello di sviluppo basato sulla neve e sull’infrastruttura meccanizzata che mostra segnali evidenti di crisi, esacerbati dal cambiamento climatico. Investimenti in cannoni da neve o marketing differenziante appaiono razionali se considerati singolarmente, ma nell’insieme diventano controproducenti, generando rendimenti decrescenti e immobilizzando risorse finanziarie.
Come nel tessile, le strategie di sopravvivenza non bastano più. Continuare a investire nello stesso modello equivale a rafforzare l’inefficienza. Per evitare il collasso futuro, sostiene Duc, le comunità alpine devono scegliere una strategia di value investing territoriale, ovvero una riallocazione intelligente del capitale verso imprese nel territorio, su filiere da individuare e costruire, per esempio su innovazione e manifattura, filiere sostenibili e produzione su misura, esattamente come fece Buffett diversificando verso l’assicurazione.
Una questione identitaria e strategica
Il problema, però, non è solo economico. Le stazioni sciistiche rappresentano per molte comunità alpine un’identità condivisa, una memoria storica e un’economia circolare che coinvolge famiglie, mestieri e territori. Come Buffett ha esitato a lungo per rispetto verso i propri operai e la comunità locale, anche le Alpi faticano a rompere con un sistema che ha garantito benessere e coesione sociale.
Tuttavia, secondo Duc, l’audacia oggi è una forma di cura collettiva. Cambiare rotta non significa chiudere le stazioni, ma creare un “secondo battello” su cui puntare.
Non è tempo di nostalgie, ma di costruire nuovi progetti capaci di garantire resilienza economica e climatica. Il vero rischio, ammonisce Duc, non è abbandonare il modello turistico classico, ma non avere un piano B.
LEGGI ANCHE: “FUTUReALPS”, in Valle d’Aosta si costruisce il futuro della “Montagna 4.0”